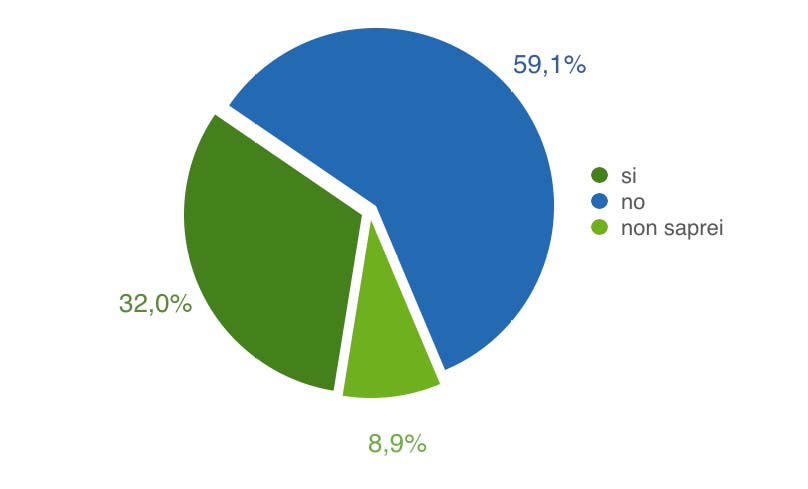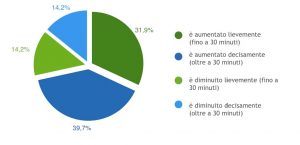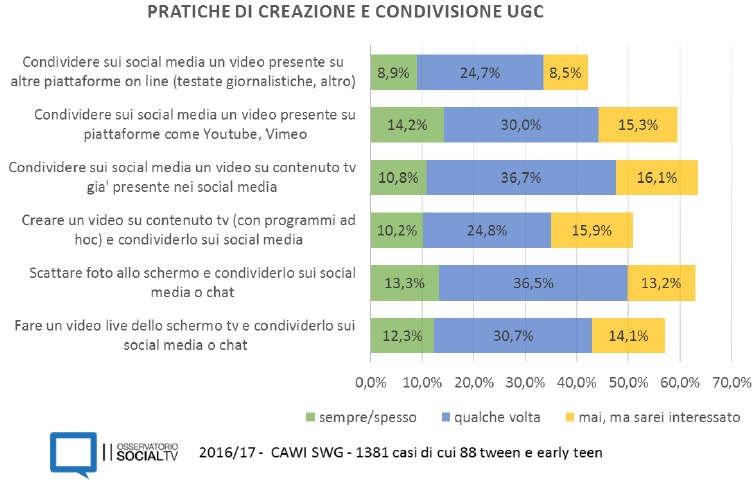Elisa Mandelli: “In Treatment, un format da soap per riflettere sulla psicanalisi”
In Treatment, un format da soap per riflettere sulla psicanalisi
Un libro edito da Mimesis analizza la serie
 Un’opera, In Treatment. La serialità in analisi (Mimesis, 2017), che per le sue ipotesi si avvale delle testimonianze di due protagonisti, Hagai Levi e Nicola Lusuardi, che hanno creato e adattato la serie. Un’occasione per riflettere su questa fiction targata Sky, tratta da un format israeliano, con una struttura da soap, e che ha visto oltre sedici adattamenti nazionali. Infine, un modo per mostrare la psicanalisi, vista attraverso l’intrattenimento, ma che tramite questo ha visto la sua diffusione all’esterno e all’interno della comunità scientifica degli psicoterapeuti. Tutto ciò, appunto, nel lavoro, uscito da pochi giorni in libreria, di Elisa Mandelli, assegnista di ricerca presso l’Università degli studi Link Campus University (Roma).
Un’opera, In Treatment. La serialità in analisi (Mimesis, 2017), che per le sue ipotesi si avvale delle testimonianze di due protagonisti, Hagai Levi e Nicola Lusuardi, che hanno creato e adattato la serie. Un’occasione per riflettere su questa fiction targata Sky, tratta da un format israeliano, con una struttura da soap, e che ha visto oltre sedici adattamenti nazionali. Infine, un modo per mostrare la psicanalisi, vista attraverso l’intrattenimento, ma che tramite questo ha visto la sua diffusione all’esterno e all’interno della comunità scientifica degli psicoterapeuti. Tutto ciò, appunto, nel lavoro, uscito da pochi giorni in libreria, di Elisa Mandelli, assegnista di ricerca presso l’Università degli studi Link Campus University (Roma).
Come nasce la sua opera, e quanto sono state utili per la sua stesura l’intervista del 2016 con Hagai Levi, ideatore e regista della serie originale, BeTipul, e quella del 2015 con Nicola Lusuardi, sceneggiatore della serie italiana?
Il libro nasce innanzitutto dalla mia passione per la serie che avevo visto anche in versione USA (In Treatment, 2008 – 2010): essa ha poi trovato una collocazione editoriale ideale quando l’editore Mimesis stava in quel periodo iniziando una collana, “Narrazioni seriali”, che prevedeva una serie di monografie interamente dedicate a serie TV.
Le interviste poi, sono state fondamentali: parlare con chi ha ideato una serie apre una prospettiva su questioni produttive, su ciò che sta alla base della costruzione dei personaggi, ecc.. È stato anche bello perché, dal momento che avevo già in parte iniziato a lavorare al libro, con Levi e Lusuardi ho potuto mettere alla prova alcune delle mie letture e interpretazioni.
Qual è il motivo del successo internazionale di In Treatment, che ha visto circa più di sedici adattamenti nazionali?
Ha avuto un successo a livello di diffusione del format perché era semplice da adattare, economico, e quindi si inscriveva bene nelle politica di reti che volevano avere prodotti finiti a un prezzo contenuto. Per quanto riguarda invece il successo in termini di pubblico, questa è una serie piuttosto di nicchia, e credo che a volte se ne sia parlato più di quanto la si sia effettivamente vista.
Hagai Levi, alla presentazione della prima serie dell’italiano In Treatment, lo ha definito “un capolavoro, l’adattamento più importante mai fatto della mia serie.” Lei è d’accordo, e questo vale anche per le altre due stagioni?
Avendo visto la versione USA e italiana, il mio giudizio è limitato al raffronto tra questi due adattamenti. Se non un capolavoro, mi sembra che In Treatment nella versione Sky sia un prodotto molto ben riuscito, che ha da una parte la capacità di rispettare le caratteristiche del format, dall’altra quella di fare degli adattamenti spesso anche piccoli e puntuali che però l’hanno reso molto coerente con il contesto nazionale.
Quanto c’è di global nel prodotto italiano e quanto di local?
In Treatment è un prodotto che da una parte si rifà alle punte più alte a livello della serialità internazionale, dall’altra è un prodotto concepito per il mercato nazionale, a partire dalla scelta degli attori, estremamente rappresentativi del panorama cinematografico e televisivo italiano.
Per quanto riguarda la caratterizzazione dei personaggi, quelli più local sono il carabiniere Dario e padre Riccardo, quest’ultimo interamente scritto dagli sceneggiatori italiani.
Dario è l’adattamento di quello che nella versione originale era un pilota dell’esercito israeliano, e in quella HBO un pilota della Marina di stanza in Iraq, entrambi colpevoli di aver ucciso in missione dei bambini come, appunto, ha fatto Dario. Nel nostro contesto si è scelto di creare questa figura di carabiniere, connotato in senso nazionale secondo due linee. Una è legata al problema delle mafie da noi molto sentito, l’altra al nostro immaginario mediatico che da La piovra in poi ha a che fare con personaggi che lottano contro la criminalità organizzata.
Padre Riccardo, mandato in analisi dal suo superiore, è espressione di quello che ancora oggi è un elemento che ci caratterizza, cioè il cattolicesimo, che mette in discussione il rapporto tra ragione e fede, tra l’analisi intesa come scienza che si basa sulla fede nella ragione e la fede come qualcosa che ha a che fare con altri valori.
Lei ha detto che in alcuni tratti In Treatment (2013 – 2017) targata Sky assomiglia a una soap. In che senso? Si può dire la stessa cosa per la versione israeliana (BeTipul, 2005 – 2008) e per quella statunitense (In Treatment)?
Assolutamente sì. Al di là della specificità dell’adattamento italiano, è la serie stessa, a partire da BeTipul, ad essere impostata come una soap. Innanzitutto per le strategie di programmazione, basata su cinque giorni la settimana, appunto, come una soap o una telenovela. Questo è successo anche per la prima stagione HBO, e così è stato fatto per tutte le tre stagioni in Italia. C’è poi, e questa è soprattutto una caratteristica di BeTipul, l’essenzialità della messa in scena: nella versione israeliana, un divano e una poltrona per l’analista e poco più, per cui risultava in primo piano il dialogo a scapito dell’azione. Altra somiglianza con le soap, sul piano narrativo l’idea di un riproporsi dei motivi di fondo che nelle soap serve allo spettatore che si è perso delle tappe perché non ha potuto seguire tutte le puntate. Il riproporsi dei motivi si sposa con i ritmi dell’analisi, ricorrenti, che ritornano sulle stesse tematiche per rileggere il tutto in nuove prospettive.
Lei afferma che lo psicoterapeuta, a sua volta in analisi, ha fatto scrivere più gli psichiatri che i mass – mediologi. Perché?
È la prima volta che l’analisi viene rappresentata in modo così realistico all’interno di una serie TV o di un film e con un tale peso in termini di spazio narrativo: In Treatment è una narrazione che si compone esclusivamente sull’analisi. La discussione su di essa da parte di esperti è avvenuta un po’ dappertutto già da quando è uscita la versione israeliana. In America ci sono state, in molte conferenze di analisti, delle sessioni dedicate ad hoc, in cui intervenivano anche sceneggiatori, produttori, spesso Hagai Levi. Ciò è avvenuto con la consapevolezza che non si trattava di un documentario sulla psicoterapia, ma di intrattenimento.
Questo è stato funzionale per gli analisti in un duplice senso: verso l’interno della comunità scientifica per l’estrema verosimiglianza che si prestava a sviluppare delle riflessioni di metodo, e ciò a partire proprio dalle imperfezioni dell’analista, che offriva lo spunto per ragionare sulla terapia, sull’utilità, sui metodi.
La serie ha però “funzionato” anche all’esterno della comunità di psicoterapeuti, e questo in Italia è stato favorito dalla stessa Sky, che ha pubblicato sul suo portale una rubrica che si intitolava “La parola all’esperto” e che ospitava i contributi degli analisti, considerati più idonei a parlare della serie rispetto a quelli che si occupavano di media. Ciò ha dato luogo a un discorso sull’analisi rivolto a chi non la conosceva dal punto di vista professionale, e ha contribuito ad orientare la sua percezione pubblica.
MARIA GRAZIA FALÀ
MARIA GRAZIA FALÀ